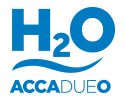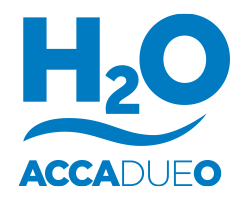Intervento a cura di Marco Fantozzi, Presidente del Gruppo Isle Utilities, con focus su alcuni degli argomenti che verranno trattati in occasione della prossima edizione di Accadueo a Bologna.
Secondo il World Risk Report le crisi idriche rientrano nella categoria dei grandi rischi globali caratterizzati da alta probabilità e alto impatto sulla popolazione mondiale dove l’area del mediterraneo è considerata tra quelle più colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico. Soprattutto in Italia stiamo vivendo un anno particolarmente difficile, caratterizzato da una grave carenza idrica al sud e da allagamenti principalmente al nord che stanno rendendo ancora più urgenti le misure di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
Ma sarebbe troppo semplice ed errato, oltre che utilitaristicamente deresponsabilizzante, attribuire tutte le colpe al cambiamento climatico. Infatti in Italia la gestione dell’acqua ha purtroppo ancora troppe ombre. Se vogliamo affrontare con successo la sfida che abbiamo inesorabilmente davanti è necessario prendere atto di tutti i fattori limitanti che finora ci hanno impedito di garantire una gestione efficiente dell’acqua, una risorsa che è tra le più scarse e preziose, e mettere in atto tutte le misure sia tecniche che politiche ed organizzative necessarie.
Ma non si tratta solo di una questione di servizio pubblico ed ambientale in quanto complessivamente, come riporta The European House Ambrosetti nel suo report valore dell’acqua 2024, l’acqua è l’elemento abilitante per 367,5 miliardi di Euro di Valore Aggiunto dove il 19% del PIL italiano non potrebbe essere generato senza l’acqua. Una gestione inefficiente dell’acqua comporta infatti una forte limitazione alla capacità produttiva del paese. Una ragione in più per dare il giusto valore alla gestione dell’acqua.
Da un lato l’Italia è uno dei Paesi che prelevano più acqua in Europa con oltre 156 m3 di acqua prelevata per abitante all’anno, dall’altro abbiamo una rete infrastrutturale obsoleta (il 60% della rete di distribuzione dell’acqua ha più di 30 anni) e poco efficiente (la perdita di rete supera mediamente il 40% dell’immesso - dati Eureau). A proposito di efficienza nella gestione delle perdite idriche va evidenziato che utilizzando indicatori tecnici di performance più significativi suggeriti dalla comunità scientifica internazionale emerge come mediamente in Italia si spreca oltre 10 volte il valore di perdita delle reti idriche ritenuto fisiologico mentre in paesi europei evoluti nella gestione delle reti come l’Olanda e la Danimarca le perdite idriche sono mantenute a livelli minimi fisiologici.
Questo è dovuto sicuramente ad uno storico limitato livello di investimenti nel settore unito in molti casi ad una scarsa efficacia degli investimenti effettuati. Anche se vediamo un trend in miglioramento dovuto sia all’intervento stimolatore del regolatore ARERA che alla più recente Linea 4.2 del Recovery Plan che ha messo a disposizione circa 2 miliardi di Euro per supportare la digitalizzazione delle reti idriche e la riduzione delle perdite, l’Italia è caratterizzata da una media quinquennale di 59 Euro per abitante all’anno, ben al di sotto della media europea di 82 Euro a causa di tariffe significativamente più basse, pari a circa 2 Euro/m3, rispetto alla media Europea pari a circa 3,2 Euro/m3.
Aumentare le tariffe adeguandole alla media europea (almeno nella fascia di consumo superiore al consumo pro capite necessario) porterebbe ad un aggravio limitato per i consumatori, non direttamente proporzionale all’aumento del prezzo al mc, in quanto l’aumento tariffario porta normalmente ad una maggiore sensibilità ad evitare gli sprechi e a ridurre i consumi non necessari, visto anche che in Italia il consumo pro capite, pari a circa il doppio di quello dei paesi del centro nord Europa, è spesso dovuto a sprechi ingiustificati ma sostenuti proprio perché poco costosi.
E’ chiaro che aumentare le tariffe consentirebbe di aumentare gli investimenti non solo nel settore specifico e migliorare il servizio ma anche di generare un significativo PIL aggiuntivo per la filiera industriale e di servizi sottesa con effetto di moltiplicatore economico, stimato da TEHA Group di circa 2,8 volte il valore di investimento diretto. Non farlo, a causa dell’incapacità politica di prendere decisioni apparentemente impopolari ma necessarie a garantire un futuro sostenibile, ci lascia in una situazione di stallo che ci porta progressivamente a pagare sempre di più, in termini di disservizi e perdite economiche. Una delle ragioni dello scarso investimento nell’efficienza idrica è certamente che è più popolare inaugurare impianti e grandi opere (a prescindere dalla loro reale utilità) che investire nelle reti idriche interrate, e perciò invisibili in quanto oggetti ma non invisibili nelle conseguenze che la loro inefficienza comporta in termini di disservizi e costi. Conseguenze che per incompetenza, comodità e mancanza di assunzione delle responsabilità spesso vengono attribuite ai soli cambiamenti climatici e non, dove presenti, alle carenze tecnico gestionali.
Spesso infatti la stessa erogazione intermittente, in particolare in molte città del sud Italia, viene descritta dai media e dai gestori come inevitabile conseguenza delle scarse precipitazioni per autoassolversi anche quando la capacità degli invasi non viene pienamente sfruttata, quando le pressioni di rete non vengono regolate adeguatamente o gli sfiori dei serbatoi non vengono impediti o quando non esiste una gestione efficiente della ricerca e riparazione delle perdite.
Spesso entrare in erogazione intermittente, che comporta sempre gravi disagi ai cittadini ed alle attività produttive oltre a rotture più elevate di tubi e deterioramento di valvole e contatori con conseguente aggravio dei costi di manutenzione, potrebbe essere evitato semplicemente riducendo le perdite mediante un uso appropriato di gestione della pressione, ricerca e riparazione delle perdite, sostituzione selettiva di condotte ecc... Ad esempio, quando le perdite sono al 50% e si fornisce ai cittadini solo il restante 50% dell’acqua prelevata dall’ambiente, anche se per effetto delle mancate piogge si potesse prelevare dall’ambiente solo il 75% della quantità originaria, questa sarebbe sufficiente a garantire tutti i consumi se le perdite venissero dimezzate. Questo senza contare che molto potrebbe essere fatto anche per limitare i consumi non strettamente necessari come già evidenziato precedentemente. Quanto sopra per dire che abbiamo ampi margini di miglioramento che non è più accettabile non esprimere in quanto le metodologie e le tecniche disponibili ce lo consentirebbero.
Quindi è indispensabile aumentare le tariffe dell’acqua per dare di conseguenza più capacità di investimento ai gestori ma ciò non sarebbe di per sé garanzia sufficiente se non viene garantita la capacità di appropriato utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dei gestori.
In questo senso è necessaria una verifica della competenza e capacità degli attuali enti gestori in base alle performance tecniche gestionali resa possibile dal ruolo del regolatore con l’estrema ratio della riassegnazione delle concessioni in caso di evidenti incapacità tecniche e gestionali che non danno garanzie di corretto uso degli investimenti. Questo vale per i gestori di dimensione inadeguata e ancor di più nel caso delle gestioni in economia caratterizzate da evidente inadeguata dimensione e incapacità tecnica.
Infatti l’efficientamento del servizio idrico ed in particolare la riduzione dei prelievi, dei consumi e degli sprechi di risorsa idrica deve passare per una decisa industrializzazione della gestione resa possibile oggi dalla disponibilità di soluzioni digitali e di smart water e dalle innovazioni e tecnologie emergenti per l’efficientamento delle reti idriche, fin qui poco implementate in Italia ma che stanno trovando ampia applicazione grazie ai progetti finanziati dalla linea di finanziamento 4.2 del PNNR.
Per la trasformazione digitale è indispensabile la reingegnerizzazione dei processi e l’acquisizione di nuove competenze tecniche e gestionali indispensabili a garantire una gestione efficiente.
Per quanto detto è evidente l’urgenza di definire interventi di natura sistemica a livello nazionale che possano favorire lo sviluppo della filiera dell’acqua e incentivare una gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica generando altresì un effetto virtuoso su tutta la filiera sottesa. In tal senso una tariffa adeguata accompagnata da una campagna di sensibilizzazione consentirebbe di dare il corretto valore alla risorsa acqua. Tale adeguamento tariffario idealmente dovrebbe essere accompagnato da misure di incentivazione fiscale associate agli investimenti per modernizzare ed efficientare sia le reti idriche che gli impianti interni per garantire il flusso di investimenti necessario a dare continuità agli investimenti del settore dopo che l’impulso del PNRR si sarà esaurito nella primavera del 2026.
Un supporto significativo al settore potrebbe essere ottenuto anche con supporti finanziari da fonti ministeriali/europee o ARERA mirati all’adozione dell’innovazione nel settore idrico, a condizione che i percorsi applicativi ed i risultati ottenuti vengano condivisi con tutti gli altri gestori (come richiesto da OFWAT in UK) in modo da massimizzarne l’effetto di replica e la ricaduta nel settore.
Analogamente sono da favorire gli approcci collaborativi all’innovazione, le interazioni tra i gestori e la sinergia con i portatori di innovazione per consentire di ridurre i costi massimizzando i benefici. Altrettanto importante è agire sull’adeguamento dell’organizzazione aziendale dei gestori e favorire l’acquisizione da parte loro delle competenze necessarie al pieno sfruttamento dei benefici connessi con la trasformazione digitale. Inoltre attualmente i gestori hanno difficoltà a dare piena applicazione alla trasformazione digitale a causa di una cronica carenza di ingegneri idraulici e di esperti di analisi dei dati dovuta anche a limiti nella capacità di assumere e di retribuire adeguatamente i profili tecnici necessari oltre alla carenza cronica di personale qualificato che spesso dopo la fine del percorso universitario trova migliori opportunità di lavoro all’estero.
E’ necessario favorire il contributo delle nuove generazioni all’efficientamento dell’uso dell’acqua con un insieme combinato di misure quali: offrire ai gestori sgravi fiscali per l’assunzione di giovani laureati altamente qualificati, adeguare l’offerta formativa delle università per il settore idrico con percorsi di studio aggiornati sulle nuove tecnologie e la digitalizzazione nel settore idrico e comprensivi di stage presso i gestori, sostenere l’adesione dei giovani ai corsi suddetti con specifici e significativi incentivi, effettuare campagne di comunicazione specifiche mirate ad evidenziare ai giovani che lavorare nella gestione dell’acqua è interessante, appassionante e remunerativo oltre a produrre un impatto ambientale e civile molto positivo.
 IT
IT  en
en